Donatella CALABI, «Venezia e il ghetto. Cinquecento anni dal “recinto degli ebrei”», Bollati Boringhieri, 2016
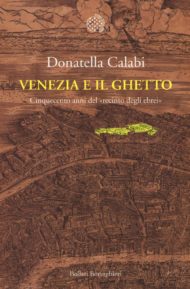
Architetta e urbanista, oltre che storica, lo sguardo dell’autrice è attento alla struttura abitativa del ghetto e alle sue trasformazioni nel tempo, all’evoluzione demografica, ai rapporti con la città del ghetto, o meglio dei ghetti (perché a Venezia erano tre, edificati in periodi successivi), sia dal punto di vista urbanistico che da quello dei contatti tra i due mondi, dei mestieri esercitati dagli ebrei, della vita religiosa e comunitaria.
Da esperta urbanista, l’autrice si sofferma sulla struttura architettonica e sull’edilizia dei ghetti, sulle case sempre più alte, sulle diverse sinagoghe nazionali e le loro decorazioni interne, contrastanti con la semplicità dell’esterno, sulle botteghe, dentro e fuori dal ghetto, sull’antico cimitero ebraico del Lido. Parallelamente, Calabi segue le vicende di insediamento in pieno centro città, negli antichi palazzi nobiliari, dei ricchi mercanti e banchieri che, dopo l’emancipazione di fine Settecento e primo Ottocento, comprarono palazzi della portata della Ca’ d’Oro (i Conegliano e poi gli Errera), esibendo all’esterno l’avvenuta ascesa sociale e il processo di integrazione. Ma ne parleremo ancora. Il ricco apparato di mappe, cartine e fotografie aiuta il lettore a capire meglio l’andamento di questi processi.
Torniamo invece all’inizio. Il primo ghetto, quello del 1516, si chiamò ghetto nuovo e prese il nome dalla fonderia di rame – geto – che si trovava nel sito di Cannaregio prescelto, che era appunto l’area del “geto”. Il ghetto nuovo accoglieva soprattutto ebrei askenaziti, di origine tedesca, che pronunciavano la g dura – geto-ghetto –, e facevano i prestatori: è il sito più noto anche oggi, insieme al suo Campo. Dunque, la prima cosa su cui riflettere è che il termine «ghetto» nasce senza avere nulla a che fare né con la reclusione né con una minoranza, ed è solo in seguito che si identifica con il «claustro» degli ebrei, per poi allargarsi per estensione – legittima o no, ne parlerò più avanti – a tutti i luoghi di segregazione. Il dato interessante di Venezia è la stratificazione nazionale, temporale e professionale che si creò all’interno del ghetto/ghetti. Nel 1541, per esigenze di accoglienza, nacque infatti, vicino al primo, il ghetto vecchio, destinato a sefarditi e levantini e anche marrani, per lo più mercanti e banchieri, comunicante con il primo con un ponte ma separato, con caratteristiche diverse perché più proiettato all’esterno, verso la città e i suoi mercati, ma anche verso Levante. Solo nel 1633 sorse il ghetto nuovissimo, destinato ad accogliere altri ebrei, per lo più benestanti e attivi imprenditori, che venivano da fuori, di cui qualcuno, come l’armatore Isac Treves, giunto da Costantinopoli, era attivo in traffici mercantili con il Nord Europa e le Americhe. Non è un caso che proprio in quegli anni di espansione si collochino due dei libri più importanti della cultura ebraica veneziana, due libri centrati sui rapporti sempre più stretti tra minoranza reclusa e maggioranza. Nel 1638 uscì infatti la Historia de’ riti ebraici, scritta dal rabbino conosciuto in tutta Europa, Leon Modena, e rivolta a un pubblico cristiano di eruditi a cui si intendeva spiegare la ritualità ebraica, depurata da ogni aspetto di superstizione. Nello stesso anno fu pubblicato anche il Discorso circa il stato de gl’Hebrei et in particolar dimoranti nell’inclita città di Venetia del rabbino Simone Luzzatto, in cui prevaleva l’approccio economico teso a dimostrare la utilità della funzione degli ebrei nello stato Veneto, e dunque la necessità della loro presenza.
I tre ghetti, con le loro differenze nazionali, linguistiche, professionali e rituali, costituivano dunque un insieme non omogeneo con differenti ruoli nella città, diverse condizioni sociali e culturali, e organizzazioni interne autonome, spesso tra di loro conflittuali. E qui viene smentito un primo stereotipo o luogo comune che vale anche per altre realtà comunitarie ebraiche: cioè che il ghetto sia stato un tutto compatto, univoco e soprattutto solidale. Si trattava invece di una società assai composita e articolata, caratterizzata al proprio interno dalla presenza di diversi gruppi etnici non di rado in lotta tra loro, come peraltro avveniva anche altrove, ad esempio nella comunità di Roma. Va anche notato che le tappe e i percorsi temporali e spaziali dei tre siti riflettono in maniera chiarissima sia l’ordine di arrivo dei diversi gruppi etnici, sia le attività e l’evoluzione professionale degli ebrei di Venezia, nonché la formazione di un élite ricca e pronta ad assimilarsi: essi testimoniano infatti il passaggio dai primi prestatori su pegno locali e mercanti dell’usato (askenaziti e ghetto nuovo) ai grandi mercanti a carattere globale e internazionale e ai banchieri-finanzieri-imprenditori (sefarditi e levantini in ghetto vecchio e nuovissimo). Si verifica cioè non solo una stratificazione socio economica all’interno delle varie nazioni e tra le nazioni stesse, ma si constata anche un percorso abbastanza lineare di cambiamento di attività e di affermazione professionale e culturale che si identifica con i luoghi.
Altro punto interessante è il fatto che a Venezia il ghetto non si stabilì come quartiere separato e chiuso su una presenza già installata da tempo – talvolta da molto tempo – in città, come avvenne a Roma, dove la presenza ebraica era più che millenaria, ma raccoglieva gli ebrei della Terraferma perché la Dominante, restia ad ammetterli stabilmente, li aveva a lungo tenuti lontani. Si potrebbe avanzare un’osservazione interessante e paradossale, per spiegare questo processo particolare e tardivo di insediamento stabile: si può sostenere infatti che Venezia fosse già di per sé troppo “ebraica”, nella sua vocazione economica, per poter dare spazio volentieri agli ebrei. Nella Terraferma gli ebrei c’erano da tempo, ma il soggiorno nella Dominante fu rinviato e ristretto per evitare la concorrenza della diaspora ebraica con le attività di una città regina dei traffici mediterranei. E infatti gli ebrei furono ammessi solo dopo la crisi seguita alla guerra di Cambrai (1508-16). Dal punto di vista dell’antichità degli insediamenti, Venezia non rappresenta quindi il modello dei ghetti italiani quanto invece lo è Roma, in cui l’elemento religioso-ideologico alla base dei claustri nell’età della Controriforma è del tutto prominente, e ampiamente teorizzato dalle autorità cristiane. Tuttavia, una volta ammessi, Venezia fece larghe concessioni e tollerò volentieri lo scambio e i legami fra gli ebrei e la città, nonostante le norme restrittive. E questo dato, relativo allo scambio con la città, costituisce un punto chiave del libro di Calabi e direi un nodo centrale in generale della storia dei ghetti in Italia. Una storia che di recente si sta rinnovando proprio sulla base dell’analisi delle relazioni tra i due gruppi all’interno delle città, che configurano una realtà non di separazione ma, appunto, di scambi.
Un altro punto cruciale e essenziale della storia dei ghetti in Italia è quello costituito dai decenni fra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, in cui si affermò l’emancipazione giuridica e politica degli ebrei, anche a Venezia. L’acquisizione della cittadinanza a tutti gli effetti non implicava soltanto la rottura del sistema di clausura e di separazione ma anche una spinta ulteriore al processo di integrazione e di assimilazione: un processo che peraltro non riguardava solo gli ebrei ma, come asserisce giustamente l’autrice, l’intera città. Infatti, l’accesso pieno al diritto di proprietà comportava l’allontanamento dei più abbienti dal ghetto e l’appropriazione della parte più bella e ricca della città, subentrando spesso al patriziato. E questo, come nota giustamente Calabi, rappresenta uno dei significativi processi di trasformazione dell’assetto urbano complessivo di Venezia, che conferma la relazione forte stabilitasi sempre più strettamente tra gli insediamenti ebraici e il tessuto urbano ed edilizio della città. Le grandi famiglie acquistarono antichi palazzi nelle aree di maggior prestigio, lungo il Canal Grande, e investirono in case e immobili in tutta la città. I Vivante, i Conegliano, gli Errera, i Franchetti, i Treves, i Bonfil, i Levi-Sullam erano committenti dei più importanti artisti, mecenati, collezionisti di opere d’arte, perfettamente integrati nella sciabilità aristocratica e alto-borghese veneziana, con i suoi riti e abitudini: salotti, balli, teatri, concerti. Tra le immagini accluse al testo ce n’è una particolarmente significativa che raffigura il ricevimento – forse un ballo – nella Sala dei Canova nel palazzo seicentesco acquistato dai Barozzi, nel 1827, da parte dei Treves di Bonfil, e ristrutturato da Leopoldo Cicognara. La sala, riccamente decorata, è dominata dalle due gigantesche statue di Ettore e di Ajace, opere di Canova, lo scultore più importante e famoso dell’epoca, e si affaccia con tre ampie finestre sul Canal Grande, mentre all’interno compare una folla elegante di invitati e di ospiti illustri, per nulla diversi dagli esponenti dell’élite cittadina non ebrea ritratta in altri quadri dell’epoca. Ma l’assimilazione, che poteva giungere fino all’acquisizione di titoli nobiliari – come avvenne al barone Franchetti e alla famiglia Treves di Bonfil (e sulla nobilitazione degli ebrei italiani nel corso dell’Ottocento sono attualmente in corso ricerche importanti) -, portava con sé anche problemi, all’interno e all’esterno della comunità, a Venezia come altrove. All’interno, l’allontanamento dal ghetto e l’acquisizione di nuovi comportamenti poteva significare un processo di secolarizzazione e di allentamento della tradizione religiosa, che impensieriva le autorità rabbiniche e comunitarie e poteva creare tensioni. All’esterno, l’assimilazione, che comportava la perdita di segni identitari specifici, come il cappello, l’abbandono del ghetto, la dispersione in città, l’esibizione della ricchezza ai fini della legittimazione e dell’integrazione, potevano produrre – e produssero – nella società cristiana una reazione di rigetto, con una ripresa dell’antisemitismo che in effetti si realizzò in tutta l’Italia dell’Ottocento. Non bisogna aspettare insomma il 1938 e le leggi razziali. Quanto più acquistava peso la presenza della borghesia ebraica nell’ élite e nella vita pubblica e amministrativa cittadina tanto più, specie nelle pieghe del cattolicesimo tradizionale, ma non solo (ricordiamo che nel 1872 si pose in Parlamento il quesito se un ebreo potesse diventare ministro), cresceva l’ostilità antigiudaica. In un libro molto acuto del sociologo Zygmunt Baumann, pubblicato in italiano nel 2014, intitolato Visti di uscita e biglietti di entrata. Paradossi dell’assimilazione ebraica, sono ben esposte le contraddizioni dell’assimilazione. Dal Settecento, in Europa, agli ebrei si chiede di assimilarsi. In cambio si promette loro l’eguaglianza. Due secoli dopo quella parabola sarebbe finita con milioni di morti. In mezzo, come racconta Bauman, il percorso è stato accidentato. Quanto più gli ebrei andavano in cerca dell’assimilazione, tanto più la diffidenza nei loro confronti cresceva. Zygmunt Bauman, in questo suo testo che risale al 1988, analizza i meccanismi culturali che stanno dietro alle richieste che le società nazionali europee, soprattutto quella tedesca, hanno rivolto agli ebrei tra Ottocento e Novecento per accoglierli, ma senza mai rimuovere le proprie diffidenze. La conseguenza fu che ancora prima dello sterminio anche i volenterosi che aspiravano all’assimilazione si trovarono in una «terra di nessuno», sospesi nel nulla. Spesso furono i primi a cadere. Scrive Bauman: «la specificità era un nemico dell’emancipazione, quindi il regno dell’universalità poteva essere raggiunto solo al prezzo dell’annientamento dell’ebraismo: la più specifica delle specificità; la specificità in quanto tale.» (p. 14). E ancora: «non può darsi un’autentica accoglienza finché l’incontro tra identità e diversità procurerà attriti; ossia finché – da parte di chi riceve come da parte di chi (si) offre – mancherà la piena consapevolezza che la diversità, proprio come l’identità, è il nucleo oscuro e irriducibile di ciascuno.» (Ibidem).
Concludo segnalando l’importanza della storia della parola «ghetto», un toponimo che, come ho detto, alle origini non aveva nulla a che fare con l’idea della segregazione né con la realtà di una minoranza specifica, ma che nei secoli ha assunto il senso lato di luogo di separazione di vari gruppi – etnici, razziali, sociali, linguistici, nazionali – percepiti come diversi e minacciosi, luogo caratterizzato da degrado, violenza e miseria, sostanzialmente pericoloso. Con un’estensione nel tempo e nello spazio a mio parere poco legittima e poco storica e in sostanza deformante, si passa spesso dal ghetto nazista a quello contemporaneo dei neri americani. Tutto nel linguaggio comune può diventare «ghetto», anche i siti in cui oggi profughi e immigrati si affollano sui nostri lidi. Ma è possibile una tale comparazione? E va incoraggiato l’abuso della parola, consueto oggi nei media?
A mio avviso, l’uso corrente e pervasivo del termine, applicato alle realtà più diverse, è fuorviante e travisante perché si riverbera all’indietro nella storia distorcendola, in quanto oggi la parola indica isolamento sociale nella città e definisce un luogo separato non per legge formale dello Stato ma per aggregazione volontaria e difensiva, una zona priva di libertà di movimento, economicamente depressa, malfamata, caratterizzata da mancata integrazione: ciò che il ghetto ebraico non era affatto. Come tutto il libro di Calabi ribadisce giustamente, il ghetto a Venezia non solo faceva parte integrante della città e della società, anche per le frequenti trasgressioni alla chiusura, ma incideva concretamente sulla fisionomia urbana, la trasformava con le sue trasformazioni. E questo, nonostante ancora alcuni storici sostengano il contrario, avveniva anche in altri claustri e perfino a Roma, dove pure il sistema delle leggi di separazione non impediva affatto relazioni, circolazioni e scambi.
Condivido dunque i dubbi dell’autrice, espressi alla fine del libro in relazione all’uso della parola «ghetto» come metafora globale che esce dalla specificità ebraica. E aggiungerei un’altra conseguenza di questo uso poco consapevole, troppo sociologico e astorico del termine, con la sua intrinseca negatività sempre uguale nel tempo e nello spazio: il nesso con il ghetto nero non rafforza forse lo stereotipo degli ebrei poveri, perseguitati, non integrati e incolti? La sociologia non sempre è utile per definire un fenomeno storico ed ha poco senso parlare di «the story of blacks as “America’s Jews”», come alcuni hanno fatto. Il cosiddetto “ghetto americano”, secondo un’espressione ripresa anche da alcuni storici (K. Stow, Il Ghetto di Roma nel Cinquecento, trad it. Roma 2014), e in particolare quello nero, in realtà non aveva nulla del ghetto europeo, né era da considerarsi un’istituzione, data la sua volontarietà, temporaneità, mancanza di chiusure fisiche e di regole costrittive imposte dall’esterno, per non parlare del divario di cultura.
E ancora, si può parlare di «revival» del ghetto in epoca nazista e poi in America e in genere fino a oggi? Tra l’altro, il richiamo al ghetto da parte nazista, dai nazisti stesso evocato, implica la rivendicazione di una continuità legittimante con il passato che mi pare non accettabile.
Dunque il problema è l’uso pervasivo della parola «ghetto» come un significato, un concetto culturale astorico, indicativo di tutto ciò che è cattivo e negativo. In questo senso, un uso così prevalente e deformato nel significato implica il mantenimento, da parte di un pubblico più o meno colto – ma pensiamo anche agli studenti – della ignoranza e della mancata consapevolezza di come e dove è nato il ghetto e di cosa fosse al suo tempo. La prospettiva tutta schiacciata sul presente cancella il passato e solo l’ottica strettamente storica può delineare e circoscrivere l’oggetto e il concetto, dimostrandone l’incomparabilità con i cosiddetti ghetti di oggi.
Il libro di Calabi mi sembra dunque un ottimo antidoto all’equivoco in quanto offre un approccio strettamente storico che delinea l’oggetto senza cascami sociologistici. Infatti, prima di parlare del ghetto come metafora globale che si sottrae alla specificità ebraica per declinarsi in modo vario e composito nel tempo e nel mondo, e prima di osare una difficile, se non impossibile, comparazione tra «ghetti» diversi che giunge fino a comprendere quelli odierni (cfr. M. Duneier, Ghetto. The Invention of a Place, the History of an Idea, New York 2016), è necessario conoscere più a fondo il concetto e la realtà dei luoghi originari, sottraendosi all’uso pervasivo e astorico della parola «ghetto» e alla sua intrinseca negatività. È difficile infatti concepire i ghetti ebraici come causa di radicalizzazione, di esplosione di violenza e di mancata integrazione.
