Giovanna Fiume, Mariti e pidocchi. Storia di un processo e di un aceto miracoloso, XL edizioni, 2008
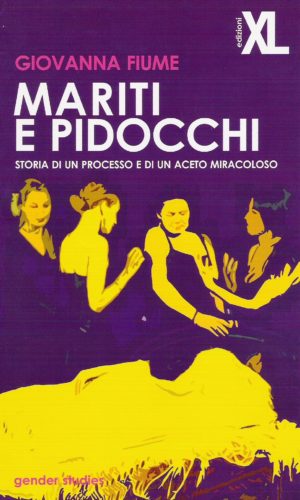
Quando, all’inizio dell’ottobre del 1788, la vinaia Maria Costanzo decide di querelare la nuora Rosa e di accusarla di aver ucciso il figlio propinandogli una bevanda avvelenata, prende il via, presso la Regia Corte Capitaniale di Palermo, una clamorosa inchiesta giudiziaria che, di lì a qualche mese, si concluderà con la condanna a morte dell’imputata Giovanna Bonanno, anche nota come la “vecchia dell’aceto”. Già dalle prime battute gli inquirenti comprendono che la morte di Francesco Costanzo non è un episodio isolato e che altri analoghi casi possono essere ricondotti all’intercessione dell’anziana vedova mendicante, in odore di stregoneria, che parrebbe tenere le fila della distribuzione di un particolare aceto, utilizzato per troncare anzitempo legami matrimoniali divenuti eccessivamente scomodi. Giovanna Fiume lascia che i numerosi attori della vicenda, tutti appartenenti al “popolo minuto” palermitano, parlino direttamente al lettore moderno: a tal fine riporta, in apertura del volume, i passi più salienti delle testimonianze raccolte nei circa mille e cinquecento fogli dell’incartamento processuale. Grazie al ricorso ad alcuni artifizi letterari che ne rendono godibile e scorrevole la lettura – altrimenti eccessivamente frammentata –, la storia del “sordo macello dei mariti” si dipana fino ad arrivare alla sentenza che ne decreta la chiusura. Ma il processo, si sa, “libera la parola” ed ecco quindi che le varie deposizioni si tramutano in un complesso caleidoscopio che affascina e stordisce al contempo. Posto di fronte a frammenti di quotidianità fatta di realtà matrimoniali condite da torbide vicende e relazioni extraconiugali (il cui filo conduttore è quello della ferrea volontà di eludere un vincolo che impedisce felicità e/o riscatto sociale), il lettore diviene preda di un vago senso di “spaesamento”, mentre una serie di domande si affacciano con prepotenza alla sua mente. Senza soluzione di continuità si immerge, allora, nella seconda parte del volume, quella in cui la storica, con un approccio foucoultiano alla fonte giudiziaria, risponde punto per punto ad ognuna delle questioni relative a “magistrati e rei” che la trascrizione degli atti processuali inevitabilmente solleva. L’episodio criminale viene così inserito nel suo contesto storico, sociale e giudiziario e sviscerato secondo i diversi e numerosi piani di lettura che in esso possono essere individuati.
In generale, quello che sembra emergere è la modernità riscontrabile sia nelle dinamiche che caratterizzano questa vicenda sia nell’approccio ad essa da parte delle autorità competenti. Echi illuministici si affacciano qua e là tra le carte, aggiungendosi al particolare non trascurabile dello scarso ricorso alla tortura durante le varie fasi dell’istruttoria. L’elemento più rilevante è, però, l’assoluta impermeabilità degli inquirenti al portato superstizioso della cultura popolare che avrebbe imposto la quasi automatica assimilazione di un delitto come quello di avvelenamento a pratiche magiche di varia natura e la costrizione della figura marginale della “vecchia dell’aceto” nella categoria tipica della strega. Per la Regia Corte Capitaniale il capo d’imputazione di Giovanna Bonanno è, invece, il “veneficio” e la donna viene condannata come “avvelenatrice” e non come “fattucchiera”, con un declassamento che può essere ricondotto alla «volontà politica di acculturazione alla giustizia illuminata» e alla volontà di «tracciare un drastico spartiacque dalla retriva pratica inquisitoriale», nel particolare contesto politico che aveva portato nel 1782 all’abolizione, da parte del vicerè Caracciolo, del tribunale del Sant’Uffizio.
La modernità, si diceva, emerge però anche dalle deposizioni delle imputate (e degli imputati) che, nel tentativo di giustificare il proprio operato, rivelano una visione dell’istituto matrimoniale e del rapporto maritale ben diversa da quella che ci si potrebbe aspettare. Proprio dalle loro parole deriva, infatti, il senso di disorientamento di cui si parlava in apertura: i loro racconti contribuiscono, involontariamente, a far crollare come castelli di carte mal costruiti certezze e stereotipi troppo saldamente radicati nella nostra memoria storica, obnubilata da falsi miti. Che fine ha fatto la società del “delitto d’onore”? Perché di fronte alla flagranza del reato di adulterio quasi nessuno dei protagonisti maschili si lascia andare al delirio della violenza? E quanto è ampio il margine di libertà che queste donne hanno all’interno di una società in cui, secondo la vulgata, dovrebbero essere tacitamente sottomesse? Il freddo calcolo delle protagoniste, portato fino alla progettazione del delitto (visto come «piccolo gesto aggiuntivo, raccontato con lo stesso flusso narrativo che caratterizza la chiaccherata oziosa con le vicine») e alla realizzazione concreta dell’omicidio, cerca una soluzione al problema del miglioramento della propria condizione di vita opposto all’ostacolo insormontabile di un vincolo matrimoniale precedentemente contratto e non altrimenti solvibile: «queste donne», cioè, «usano la sessualità come risorsa […], finalizzata per lo più alla loro mobilità sociale».
Alla luce di quanto si va leggendo negli atti processuali presentati dall’autrice, le immagini della famiglia urbana e dell’istituto matrimoniale non possono non subire una drastica rielaborazione. Proprio in questa spontanea considerazione risiede il nodo centrale del lavoro.
Chi abbia avuto la sensazione di aver già letto questo volume, può tranquillizzarsi: Mariti e pidocchi è infatti la riedizione di un lavoro di Giovanna Fiume datato 1990. Il senso di questa ristampa è spiegato nella breve nota che l’autrice antepone alla nuova edizione del suo lavoro, oggi per i tipi della XL di Roma, una casa editrice il cui catalogo presenta una sezione di gender studies, inaugurata nel 2007 da un volume miscellaneo, curato dalla stessa Fiume e dedicato a Donne diritti democrazia.
Nella breve ma appassionata nota introduttiva, dunque, l’autrice offre la vera e profonda chiave di lettura del lavoro. Ecco quindi che il saggio si pone come richiamo alla memoria storica, rivolto anche a quanti – politici, intellettuali e opinionisti vari – in questi ultimi anni si siano prodigati – e si stiano ancora pervicacemente prodigando – in difesa di un concetto monolitico e immutabile di unione matrimoniale, consapevolmente (e, quindi, colpevolmente) dimentichi di una serie di ricerche storiche (di cui questo volume è parte integrante) che rivelano una realtà ben diversa. Come sottolinea Giovanna Fiume, se la storia fosse stata, almeno per una volta, adeguatamente interrogata, «avrebbe smascherato la fallacia degli universali e la naturalizzazione (e eternizzazione) di strutture sociali mutevoli. Ci avrebbe mostrato quantomeno una variegata congerie di “forme” di famiglia, anzi di “aggregati domestici”, in ragione delle molteplici variabili, legate alle risorse e alla maniera di appropriarsene».
