Una Cartagine adriatica: il modernismo a Trieste e il mito fenicio

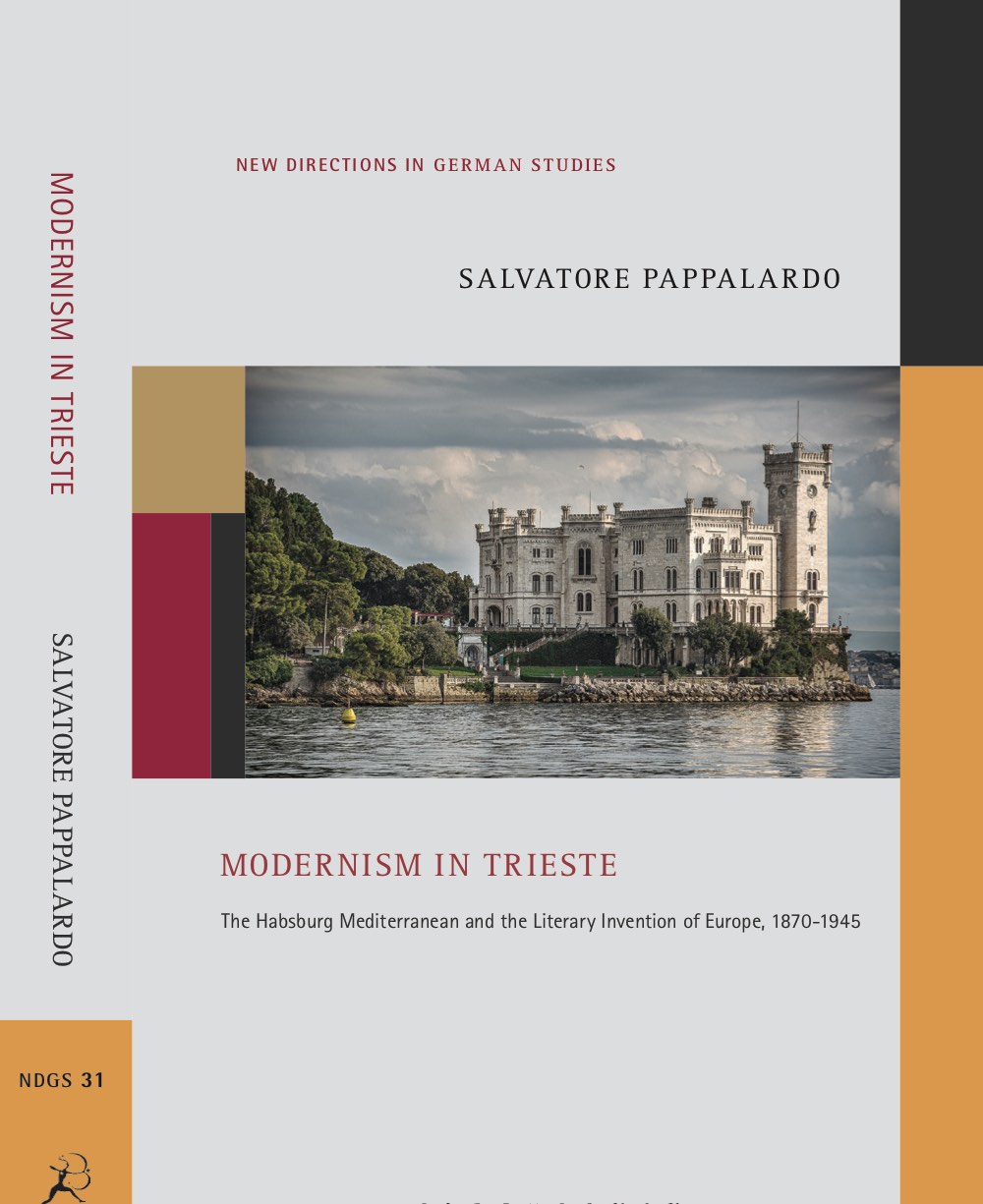
Phlebas il Fenicio, da quindici giorni morto,
Dimenticò il grido dei gabbiani, e il fondo gorgo del mare,
E il profitto e la perdita.
Una corrente sottomarina
Gli spolpò le ossa in sussurri.
T.S. Eliot, La terra desolata, 1922
Il mito triestino, in qualche modo, rinasce, come la Fenice – richiamo qui non casuale – ogni volta di nuovo dalle proprie ceneri. Artefice della sua ultima resurrezione un Claudio Magris giovanissimo, che nell’anno epocale 1963, a neppure un decennio dal definitivo passaggio di Trieste all’Italia, per virtù di carri armati più che di diritto internazionale (ex facto oritur ius…), e a poco più di un decennio dallo sciagurato Trattato di Osimo, che sanciva per sempre il destino slavo di quel che rimaneva dell’Adriatico orientale italiano – insomma a metà di un cammino forse evitabile ma immensamente doloroso – pubblicava presso Einaudi Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna. Da allora fino a Danubio e oltre Magris insiste, con ottimi argomenti, sul valore assoluto della cultura “mitteleuropea”, anche se forse la geopolitica – e la storiografia – fanno sfumare sempre più i contorni di quell’“Europa di mezzo” che alla fine non si sa in quale orbita graviti, e ove l’elemento slavo è da sempre molto peculiare, e molto – per certi aspetti – “orientale”, e dove altre componenti connotative, da quella ungherese a quello turca, non giuocano forse la parte che dovrebbero, almeno nelle trattazioni.
Singolarmente, il magistero di Magris venne rinnovato quando lo scrittore pubblicò, nel 1982, e sempre presso Einaudi, Trieste. Una identità di frontiera, volume che ebbe successo, venne ripubblicato nel 1997, e che contribuì tra l’altro in modo decisivo alla mia personale formazione, insieme a quella di alcuni altri giovani genovesi che proprio nel 1982 facevano il loro ingresso presso Lettere e Giurisprudenza nell’Ateneo genovese. Co-autore del felice volume Angelo Ara (1942-2006), nativo di Stresa, a lungo ordinario di Storia moderna presso l’ateneo pavese, studioso di amplissime vedute, a cui dobbiamo scritti fondamentali per il tema, a partire, almeno, da Ricerche sugli austro-italiani e l’ultima Austria, del 1974, fino alla cospicua raccolta di articoli postumi curati dallo stesso Magris presso Garzanti nel 2009, Fra nazione e impero: Trieste, gli Asburgo, la Mitteleuropa.
Nella Genova negli anni Ottanta del secolo passato – mi si perdoni questo breve inciso autobiografico – il mito triestino era filtrato, in gran parte, da Eugenio Montale, il cui carteggio con Svevo e i cui scritti (generalmente positivi) sullo scrittore triestino erano stati curati da Giorgio Zampa per Mondadori nel 1976. Questo veniva ad alimentare l’interesse che il gruppo di studenti di cui facevo parte nutriva – forse in cerca di multiculturalità e “identità di frontiera” in una Genova assai meno liminale e culturalmente esplosiva rispetto a Trieste, e legata se mai a sospettose relazioni verso Occidente, e la sola Francia – per quelle figure di triestini e triestinità come Bobi Bazlen, per citarne solo uno, i cui scritti venivano pubblicati proprio nel 1984 da Adelphi. Adelphi era l’editore per cui Bazlen aveva lungamente lavorato (e che segnò il nostro percorso di formazione). Ed ecco che il futuro storico del diritto Riccardo Ferrante si dedicava, ad esempio, alla prosa letteraria, e cercava modelli in Fulvio Tomizza tra gli altri (ma Ferrante è legato per ragioni familiari a Trieste); mentre personalmente, complice un Sergio Campailla che allora era attivo a Genova, studiavo – pubblicando sul giovane filosofo goriziano il primo saggio che abbia mai dato alla luce, nel 1984 – Carlo Michelstaedter, affascinato tra l’altro proprio da una Gorizia “divisa”, e alla fine non troppo affascinante, a ben vedere, tuttora. La presenza a Genova dello studioso di psicanalisi Michel David allargava alcuni dei nostri orizzonti – sempre in direzione mitteleuropea – verso il territorio di Freud, che sollecitava un musicista come Francesco Denini. Un giurista come Alessandro Morini da parte sua mostrava interessi forti per Karl Kraus. Insomma, si instaurava un tenue ma significativo legame con quella Mitteleuropa che trovava in Italia, alla fine, così tanti cultori. Da Michelstaedter poi passai a tradurre Weininger, e finalmente trasportai in lingua italiana– credo il primo a farlo – alcune poesie di Theodor Däubler, figura peraltro ancora tutta da scoprire. In qualche modo si compiva un abbraccio tra lidi adriatici e riviere liguri, forse solo episodico, ma significativo di tensioni e insoddisfazioni, che poi avrebbero preso strade peculiari, per ciascuno di noi differenti.
Uscito nel 2021, e dunque quasi quarant’anni dopo rispetto alle lontane esperienze che ho ricordato, il volume di Salvatore Pappalardo, Modernism in Trieste. The Habsburg Mediterranean and the Literary Invention of Europe 1870-1945 (London-New York, Bloomsbury), è una mirabile ricostruzione di un panorama letterario tanto multilinguistico quanto inquieto, tanto vario quanto difficile, assai spesso, da comprendere sotto il medesimo sguardo, se non altro per la necessità di conoscere l’italiano, il tedesco, il croato, e forse anche l’ungherese. Nato da uno studioso di letterature comparate – attivo in Maryland presso la Towson University – in grado di dominare almeno tre delle quattro lingue ora citate – e anche il “dialetto” triestino, che è dialetto nella misura che è variante del veneto – il volume affronta figure centrali del panorama letterario del tempo, alcuni triestini in tutti i sensi, Italo Svevo e lo stesso Däubler, altri triestini solo per brevi ma significativi periodi (James Joyce); altri ancora, finalmente, ospiti della città per poco tempo o addirittura per qualche settimana, come Freud. L’idea di fondo del libro è chiara: in un modo o nell’altro tutti questi scrittori cercano di creare ciascuno a modo proprio alternative alla costruzione politica nazionalistica che stava mettendo fine proprio a quell’armonia multilinguistica e multiculturale, a quel “Landespatriotismus” non legato allo stato centralizzato (e sempre più accentratore). Si trattava di un singolare patriottismo non nazionalistico, che aveva caratterizzato dall’inizio il Sacro Romano Impero, in tutte le sue metamorfosi, almeno fino al momento in cui la sua ultima, l’Impero Austro-Ungarico, si stava avviando nella direzione della progressiva germanizzazione delle proprie provincie, Trieste inclusa, suscitando, e accompagnando, la parallela spinta “irredentistica” italiana, e la fine di quel “mondo di ieri” forse idealizzato da Stephan Zweig nel suo capolavoro, ma certamente – dal punto di vista liberale – assai più libero, appunto, vario, ricco e pacifico rispetto al mondo creato (e devastato) dagli Stati nazionali.
Pappalardo domina una letteratura sempre crescente, inserendo il discorso nel quadro più generale dei “Mediterranean Studies”, e di quel Mediterraneo absburgico di cui Trieste fu centro, molto più di Venezia, ma in modo esclusivo nel momento in cui Venezia passò all’Italia nel 1866. Da allora Trieste è fulcro di cultura unico nell’Adriatico, pur non avendo (ma forse come per Venezia ciò fu una fortuna) un’università fino al 1924. Trieste fu luogo di incontro di etnie religioni e lingue, emporio ricchissimo e vivacissimo; tanto che il giovane Luigi Einaudi all’indomani della Grande Guerra ebbe a dire che l’unico acquisto buono per l’Italia dopo l’immensa carneficina era stato proprio quel porto, baciato da fondali profondi e culmine estremo verso Nord del Mediterraneo. Posto peraltro che l’inclusione dell’Adriatico nel “Mediterraneo” era ancora messa in dubbio da geografi, storici e politici a metà Ottocento e fino ai primi del Novecento. Il passaggio dalla Trieste austriaca a quella italiana non fu molto felice; ma del resto venne considerato inevitabile, e le ragioni degli irredentisti non erano marginali: la germanizzazione progrediva spedita, così come gli stessi interessi absburgici gravitavano sempre più verso la Prussia, ed in generale verso Nord (da qui anche l’insoddisfazione degli ungheresi nei confronti dell’Impero – ungheresi che peraltro si vedevano fratelli degli Italiani nel Risorgimento parallelo che ebbero entrambe le nazioni). In qualche modo la battaglia di Lissa aveva creato imbarazzo anche ai vincitori (ai vinti costò suicidi e processi, e la caduta in disgrazia forse immeritata dell’Ammiraglio Persano); la flotta nell’Adriatico privato di Venezia contava assai meno delle truppe di terra, il cui centro di gravità stava a Vienna, Praga o Budapest, fino a pendere poi verso Berlino.
Tra le strategie ed i richiami ideali ad un passato “di libertà”, dal giogo romano, ma anche greco del Mediterraneo, giogo che sembrava ripresentarsi con la crescita esponenziale della centralizzazione viennese e romana, ma anche slava (a modo proprio, naturalmente: e sono straordinarie le vedute al riguardo, discusse qui da Pappalardo, del poeta modernista Srečko Kosovel – che visse assai poco, dal 1904 al 1926, ma in tempo per assistere desolato al trattato di Rapallo, che assoggettava la minoranza slovena triestina e non solo triestina all’Italia fascista), ecco che compare il mito della Trieste fenicia. E la trattazione di questo argomento, davvero originale, è al centro del libro di Pappalardo. Che vi fosse una civiltà non solo pre-greca e pre-romana, ma addirittura pre-giudaica, o almeno parallela a quest’ultima ed assai affine ad essa, la quale poteva assicurare una quota di libertà, un ideale di commercio e scambio, di tolleranza religiosa, ad un Mediterraneo assoggettato poi come “Mare nostrum” al mondo latino, ebbene questo poteva solleticare numerosi ingegni, prospettare politiche europeistiche non nazionalistiche, e finalmente lasciar libero spazio alla fantasia. Il mito di un’origine fenicia di Trieste circola eccome a partire dai primi decenni dell’Ottocento. Mentre storici come Theodor Mommsen esaltano, già a metà secolo, il mondo punico come società mercantile poco legata alle strutture opprimenti di uno stato centralizzato. Allo stesso tempo la misteriosa civiltà fenicia, le cui tracce restano soprattutto grazie al mondo greco e latino, diviene oggetto di ricerche solo in parte anticipate nel secolo dei Lumi, da un Barthélemy ad esempio (figura straordinaria), che nel 1758 decifra l’alfabeto fenicio. Non ostante gli attacchi da parte di un Renan, ad esempio, che vede limiti intellettuali immensi sia nei fenici sia negli ebrei, e li individua nella semplicità sintattica delle loro lingue (ma per quanto la lingua fenicia rimanga in gran parte misteriosa), la ricerca ottocentesca, forse anche sulla spinta di quanto stava avvenendo per la civiltà “similare” e altrettanto oscura fino a Napoleone, degli egizi, compie passi da gigante nel mettere in luce documenti, e produrre interpretazioni, della civiltà fenicia: F. E. Movers pubblica Die Phönizier, in tre volumi tra il 1841-1856, con immane mole documentaria; e R. Pietschmann, Geschichte der Phönizier, nel 1889 (tradotto quasi subito in italiano), mentre G. Rawlison dà alle stampe Phoenicia, Londra 1899, e G. Contenau, La civilisation phénicienne, Parigi 1926. I fenici occupano – per concludere questa brevissima rassegna – una parte importantissima nell’opera seminale di Eduard Meyer, Geschichte des Altertums (Stoccarda-Berlino 1931). Insomma tutta l’Europa accademica, Francia, Germania e Inghilterra, si occupa della misteriosa civiltà mediterranea. Non sembrano esserci in queste opere significative indicazioni rispetto ad un’origine fenicia di Trieste – legata se mai come tutto il territorio agli Illiri – ma un buon numero di antichisti triestini cerca di sostenere tale tesi. Certamente, come mostra bene Pappalardo, sarà pure una “invenzione di tradizione” assai debole, ma il mondo fenicio, un mondo “libero”, ideale, mercantile, fatto anche di astuzie e violenze (singolarmente, Odisseo è in fondo, per le sue astuzie, un vero fenicio, eppure è greco), ma essenzialmente lontano dallo statalismo nazionalistico crescente, ispira molti scrittori. E questo proprio all’insegna del cosmopolitismo ed universalismo che regnano a Trieste, città dalle molteplici anime, e che ancora oggi coltiva un legittimo sogno di indipendenza (ed è talora vista come Nuova Gerusalemme, addirittura). Mentre però, più prosasticamente, il porto è stato di fatto acquisito da una società tedesca, nel 2020, la Hamburger Hafen und Logistik Ag (Hhla), operatore del porto di Amburgo – quasi a realizzare il sogno di una “Amburgo nell’Adriatico” di cui si parlava tra Otto e Novecento. Peraltro, il tutto è accaduto con uno strano comportamento della UE, la quale ha bloccato l’acquisto da parte italiana – ovvero di Fincantieri – dei cantieri navali francesi STX, col pretesto di violazione di concorrenza… Non è accaduto lo stesso con l’operazione amburghese a Trieste? Ed ecco che – per tornare alla nostra rassicurante dimensione letteraria — lo Zeno di Svevo diviene Zenone il fenicio (per vaghe origini), lo Zenone di Cizio fondatore dello stoicismo, piuttosto che lo Zenone eleatico (peraltro, la stessa ambiguità è in Dante, nel IV dell’Inferno: quale Zenone il Sommo Poeta incontrò davvero nel Limbo, in illustrissima filosofica compagnia?). Mentre Freud si diletta di cose fenicie, e Joyce paragona il mondo antico irlandese con il libero mondo fenicio, rilevando, in piena guerra civile irlandese, il dramma degli imperi legati a stati nazionali e centralizzatori, Däubler e Nietzsche parlano alla fine positivamente dei fenici – per quanto li conoscono – e ugualmente fa uno storico che qui viene spesso citato, Guglielmo Ferrero. Nelle opere dedicate alla storia romana, ma anche in quella, straordinaria e vasta, del 1914, Ancient Rome and Modern America, Ferrero riconosce un’importanza fondamentale ai fenici. Soprattutto per la costruzione dell’identità europea, e non solo mediterranea: portatori di commerci, spiriti liberi, vengono ritenuti tali non per nulla da un liberale classico quale Ferrero. Insieme al diritto romano, alla filosofia greca, alla religione monoteistica ebraica, la mercatura fenicia è fomite di civiltà, e suo perpetuo fondamento. Questa la tesi di Ferrero. E non potrebbe essere altrimenti.
Il libro si conclude con un riferimento alla celebre conferenza di Musil del 1934, su chi sia uno “scrittore serio”, ove si loda il cosmopolitismo, la tolleranza, il pensiero liberale (con parole che potrebbero essere state scritte da Zweig), insomma il contrario del totalitarismo imperante allora, e purtroppo trionfante, di lì a poco, nei massacri vari della guerra e della Shoah. Il mondo fenicio, “inferiore” rispetto a quello romano, riaffiora nei modi più diversi come (sogno di) alternativa alla statalizzazione e centralizzazione crescente, mentre proprio l’Inno di Mameli – ed è significativo – vede nell’ “elmo di Scipio” l’avvenuta vittoria della civiltà latina su un mondo non definibile “barbaro”, ma neppure romano o greco. Un mondo differente. Ma che è meglio tenere sottomesso o proiettare in un lontano passato. Ora le rovine di Cartagine sono miserrima cosa in una Tunisi abbruttita da dieci anni e oltre di ritorno di fondamentalismo.
Modernism in Trieste dischiude un mondo letterario ove le ansie per un’Europa confederata nel segno della libertà si confrontano con i pacifismi e le utopie post-belliche, da Fried a Schmitt, ma dove si intuiva bene che gli stati nazionali avrebbero portato ad un azzeramento delle diversità e pluralità davvero totalitario: tanto alla fine che lo stesso Svevo faticò ad entrare nel canone della letteratura italiana (e qui Pappalardo lo definisce “scrittore asburgico”); e la urbs europeissima, Trieste secondo lo storico Eduard Winkler, ha vissuto decenni da città provinciale, nostalgica di un Impero che però già da ben prima che finisse, tragicamente, aveva tradito il proprio spirito decentralizzante e multiculturale. Come mostrano bene vari libri, ad esempio quelli di Marina Cattaruzza e Elio Apih. Un mito orientalistico pervadeva Trieste, anche la Trieste di un irredentista come Silvio Benco: la sua opera del 1898, Oceana, ci parla di una Siria all’epoca dei Patriarchi dove il mondo fenicio non è proprio per nulla tramontato, le popolazioni dei siri e dei fenici, semitiche, hanno affinità numerose. Ebbe l’onore e l’onere di essere rappresentata per la prima volta alla Scala il 22 gennaio 1903 diretta da Toscanini. Tra il pubblico pare vi fosse D’Annunzio. Ma non le arrise gran successo. Mentre Wagner faceva rivivere e ricostruiva la mitologia germanica, con ben altri esiti, il tentativo di Benco e Antonio Smareglia (nativo di Pola) finì in poca cosa, ma fece immergere i triestini e gli italiani in un favoloso oriente, forse non fenicio, ma che in fondo avrebbe potuto benissimo esserlo. Verdi proietterà nell’Oriente semitico l’ansia di liberazione italiana. La fantasia di Benco è molto più confusa, decadente, sognante e vaga come il poema di Däubler.
